Primi di settembre del 1964. Giuseppe Ungaretti chiede un favore all’amico Ferruccio Scaglia, direttore dell’orchestra sinfonica della RAI. È appena giunto a Roma un giovane poeta brasiliano, interessato a tradurre le sue poesie in portoghese. Gli ha appena
della RAI. È appena giunto a Roma un giovane poeta brasiliano, interessato a tradurre le sue poesie in portoghese. Gli ha appena trovato una sistemazione presso un pensionato per studenti, ora vorrebbe trovargli compagnia, in modo che lo lasci respirare un po’.
trovato una sistemazione presso un pensionato per studenti, ora vorrebbe trovargli compagnia, in modo che lo lasci respirare un po’. Scaglia ha un figlio sui vent’anni, Franco, che ama scrivere. Potrebbe fargli da chaperon? Scaglia parla col figlio; Franco non ne vuol
Scaglia ha un figlio sui vent’anni, Franco, che ama scrivere. Potrebbe fargli da chaperon? Scaglia parla col figlio; Franco non ne vuol sapere, ma ha un amico che scrive poesie, e gli chiede a sua volta di provare ad occuparsene.
sapere, ma ha un amico che scrive poesie, e gli chiede a sua volta di provare ad occuparsene.  Fu così che, per fare un favore a Franco Scaglia, andai a cercare Bruno Tolentino alla Foresteria del Foro Italico, un complesso di
Fu così che, per fare un favore a Franco Scaglia, andai a cercare Bruno Tolentino alla Foresteria del Foro Italico, un complesso di palazzine di fronte al MInistero degli Esteri dove trovano alloggio giovani stranieri con borse di studio.
palazzine di fronte al MInistero degli Esteri dove trovano alloggio giovani stranieri con borse di studio. Tolentino aveva 24 anni, quattro più di me. Riusciva già ad esprimersi in italiano con proprietà di linguaggio e non molti errori.
Tolentino aveva 24 anni, quattro più di me. Riusciva già ad esprimersi in italiano con proprietà di linguaggio e non molti errori. La sua pronuncia era ancora molto brasileira, ma in un paio di mesi avrebbe assimilato la lingua fin quasi a non farsi riconoscere come
La sua pronuncia era ancora molto brasileira, ma in un paio di mesi avrebbe assimilato la lingua fin quasi a non farsi riconoscere come straniero. Le uniche imperfezioni le aveva nello scrivere: l’uso improprio delle doppie e del plurale dei sostantivi. Gli sono rimaste
straniero. Le uniche imperfezioni le aveva nello scrivere: l’uso improprio delle doppie e del plurale dei sostantivi. Gli sono rimaste anche perché, con segreta soddisfazione, mi sono sempre ben guardato ad aiutarlo a corigersi: cosa non fa l’invidia.
anche perché, con segreta soddisfazione, mi sono sempre ben guardato ad aiutarlo a corigersi: cosa non fa l’invidia. Facemmo subito amicizia, parlavamo quasi solo di poesia. Non so dove trovasse il tempo per vedere Ungaretti: stavamo sempre
Facemmo subito amicizia, parlavamo quasi solo di poesia. Non so dove trovasse il tempo per vedere Ungaretti: stavamo sempre insieme. D’altra parte non mi ha mai mostrato neanche l’abbozzo di una traduzione dei versi del nostro grande poeta, né mi risulta
insieme. D’altra parte non mi ha mai mostrato neanche l’abbozzo di una traduzione dei versi del nostro grande poeta, né mi risulta abbia mai pubblicato niente a tal riguardo. Se pure ha mai lavorato con/per Ungaretti, è finito tutto nel cestino. Chi ne sa di più si
abbia mai pubblicato niente a tal riguardo. Se pure ha mai lavorato con/per Ungaretti, è finito tutto nel cestino. Chi ne sa di più si faccia avanti, anche perché é finita pure sui giornali italiani la leggenda che sia stato addirittura suo ospite. Forse a colazione, un paio
faccia avanti, anche perché é finita pure sui giornali italiani la leggenda che sia stato addirittura suo ospite. Forse a colazione, un paio Ricordo che la prima cosa che mi colpì fu che se ne andasse in giro con buona parte del viso dietro una dozzina di piccoli cerotti.
Ricordo che la prima cosa che mi colpì fu che se ne andasse in giro con buona parte del viso dietro una dozzina di piccoli cerotti. Mi disse che servivano a nascondere alcuni sfoghi, forse di fegato. Mi accorsi poi che, dietro, la pelle era del tutto sana. Saperlo
Mi disse che servivano a nascondere alcuni sfoghi, forse di fegato. Mi accorsi poi che, dietro, la pelle era del tutto sana. Saperlo protetto da quei cerottini come un cavaliere dalla visiera dell’elmo me lo fece percepire nella sua fragilità e fece sì che cominciassi ad
protetto da quei cerottini come un cavaliere dalla visiera dell’elmo me lo fece percepire nella sua fragilità e fece sì che cominciassi ad affezionarmi a lui.
affezionarmi a lui. Cominciai presto a portarlo a mangiare a casa mia. Faceva ancora caldo, sulla camicia a maniche corte, spesso a scacchettoni,
Cominciai presto a portarlo a mangiare a casa mia. Faceva ancora caldo, sulla camicia a maniche corte, spesso a scacchettoni, portava sembre un gilè bordato che sapeva molto di Sudamerica. Papà lo guardava con una punta di ironia nello sguardo. Non si lasciò
portava sembre un gilè bordato che sapeva molto di Sudamerica. Papà lo guardava con una punta di ironia nello sguardo. Non si lasciò mai sfuggire un apprezzamento, ma amava chiamarlo (in assenza) Buffalo Bill. Il messaggio che intendeva lanciarmi con quel
mai sfuggire un apprezzamento, ma amava chiamarlo (in assenza) Buffalo Bill. Il messaggio che intendeva lanciarmi con quel soprannome era fin troppo chiaro: nonostante i sorrisi e i suoi modi compiti, nonostante l’immensa erudizione multilingue di cui
soprannome era fin troppo chiaro: nonostante i sorrisi e i suoi modi compiti, nonostante l’immensa erudizione multilingue di cui faceva noncurante sfoggio, si trattava di un avventuriero da cui stare in guardia.
faceva noncurante sfoggio, si trattava di un avventuriero da cui stare in guardia. Mio padre era un professionista dell’alta borghesia, uso a poche parole e all’understatement: quando era sostituto avvocato
Mio padre era un professionista dell’alta borghesia, uso a poche parole e all’understatement: quando era sostituto avvocato generale dello Stato, riempiva i moduli alla voce “professione” limitandosi a scrivere: “impiegato statale”. Il criterio ispiratore della sua
generale dello Stato, riempiva i moduli alla voce “professione” limitandosi a scrivere: “impiegato statale”. Il criterio ispiratore della sua vita era l’oraziana aurea mediocritas. Faceva l’avvocato e l’unico figlio maschio, nonostante ahimé scrivesse versi, non a caso studiava
vita era l’oraziana aurea mediocritas. Faceva l’avvocato e l’unico figlio maschio, nonostante ahimé scrivesse versi, non a caso studiava giurisprudenza. Non aveva alcuna intenzione di farselo portar via. Per di più aveva ancora in casa una figlia femmina appena
giurisprudenza. Non aveva alcuna intenzione di farselo portar via. Per di più aveva ancora in casa una figlia femmina appena diciannovenne; ma Bruno puntava a me e si teneva prudentemente a distanza da Francesca; era troppo intelligente per mettere mio
diciannovenne; ma Bruno puntava a me e si teneva prudentemente a distanza da Francesca; era troppo intelligente per mettere mio padre in ulteriore allarme.
padre in ulteriore allarme. Dell’aurea mediocritas, si sa, fa parte anche una normale vita sessuale, e nel 1964 era considersato normale che un ventenne (oggi
Dell’aurea mediocritas, si sa, fa parte anche una normale vita sessuale, e nel 1964 era considersato normale che un ventenne (oggi un dodicenne) avesse già avuto le sue prime “esperienze”. Purtroppo quella baciapile della Merlin era riuscita sei anni prima a far
un dodicenne) avesse già avuto le sue prime “esperienze”. Purtroppo quella baciapile della Merlin era riuscita sei anni prima a far chiudere i bordelli e le puttane non erano più sotto vigilanza medica. Mio padre finì così col rivolgersi a quel Buffalo Bill dall’aria
chiudere i bordelli e le puttane non erano più sotto vigilanza medica. Mio padre finì così col rivolgersi a quel Buffalo Bill dall’aria vissuta perché si adoperasse a liberarmi dalle fisime bigotte (frutto dell’influenza che Padre Pio esercitava su mia madre, sua figlia
vissuta perché si adoperasse a liberarmi dalle fisime bigotte (frutto dell’influenza che Padre Pio esercitava su mia madre, sua figlia spirituale) e potessi finalmente entrare nel mondo adulto lasciandomi dietro gli impacci della verginità.
spirituale) e potessi finalmente entrare nel mondo adulto lasciandomi dietro gli impacci della verginità. Fu così che Bruno ed io, nel novembre del 1964, avemmo con mia sorpresa via libera per trascorrere nella casa di Capri una
Fu così che Bruno ed io, nel novembre del 1964, avemmo con mia sorpresa via libera per trascorrere nella casa di Capri una ventina di giorni. A Capri Bruno si adoperò attivamente a liberare dalle fisime bigotte le giovani straniere che alloggiavano al
ventina di giorni. A Capri Bruno si adoperò attivamente a liberare dalle fisime bigotte le giovani straniere che alloggiavano al Quisisana con la mamma. Quanto a me, si adoperò attivamente per liberare dagli impacci della verginità il mio posteriore. La notte
Quisisana con la mamma. Quanto a me, si adoperò attivamente per liberare dagli impacci della verginità il mio posteriore. La notte che, dopo una giornata passata a scrivere versi, entrò al buio nella mia stanza e si infilò tutto nudo nel mio letto, la custodisco nella
che, dopo una giornata passata a scrivere versi, entrò al buio nella mia stanza e si infilò tutto nudo nel mio letto, la custodisco nella memoria, come Gedeone la notte in cui sconfisse i figli dell’oriente - più numerosi delle cavallette - con trecento brocche e trecento
memoria, come Gedeone la notte in cui sconfisse i figli dell’oriente - più numerosi delle cavallette - con trecento brocche e trecento fiaccole. Ero solo un ragazzino nevrotico, del tutto infatuato di uno degli uomini più fascinosi che Dio abbia messo al mondo nel
fiaccole. Ero solo un ragazzino nevrotico, del tutto infatuato di uno degli uomini più fascinosi che Dio abbia messo al mondo nel ventesimo secolo. L’unica cosa di me che gli diedi quella notte fu la catenina d’oro con la Madonna di Pompei che portavo al collo. In
ventesimo secolo. L’unica cosa di me che gli diedi quella notte fu la catenina d’oro con la Madonna di Pompei che portavo al collo. In più di quarant’anni di amicizia, nonostante la sua conclamata bisessualità e il reciproco affetto, non mi si è avvicinato mai più così.
più di quarant’anni di amicizia, nonostante la sua conclamata bisessualità e il reciproco affetto, non mi si è avvicinato mai più così. Cinque anni dopo, uno psicanalista mi avrebbe detto che non riusciva in alcun modo a spiegarsi come allora non fossi diventato
Cinque anni dopo, uno psicanalista mi avrebbe detto che non riusciva in alcun modo a spiegarsi come allora non fossi diventato omosessuale. Mio padre non ne ha mai saputo nulla.
omosessuale. Mio padre non ne ha mai saputo nulla. Sono solo uno dei tanti/e che hanno subito, in Europa come in Brasile, il fascino di Bruno Tolentino e che hanno vissuto con lui
Sono solo uno dei tanti/e che hanno subito, in Europa come in Brasile, il fascino di Bruno Tolentino e che hanno vissuto con lui un’amicizia mai su un piano di parità, se non per pochi eletti di cui non ho notizia. Mi ha impressionato per i punti di contatto con la
un’amicizia mai su un piano di parità, se non per pochi eletti di cui non ho notizia. Mi ha impressionato per i punti di contatto con la mia esperienza il ricordo di lui, pubblicato nell’aprile 2008 dal giornalista inglese Chris Miller, che è stato suo amico e convivente.
mia esperienza il ricordo di lui, pubblicato nell’aprile 2008 dal giornalista inglese Chris Miller, che è stato suo amico e convivente. Conferma in pieno l’idea che mi ero fatto dei 15 anni vissuti da Bruno in Inghilterra
Conferma in pieno l’idea che mi ero fatto dei 15 anni vissuti da Bruno in Inghilterra Per ora la mia testimonianza si ferma qui. Voglio solo provare a descrivere quale posto occupa l’amicizia con Bruno nella mia
Per ora la mia testimonianza si ferma qui. Voglio solo provare a descrivere quale posto occupa l’amicizia con Bruno nella mia vita. Per me, presto rimossa - e non so come - la disavventura di Capri, Bruno è stato la molla che mi ha spinto a rompere il bozzolo
vita. Per me, presto rimossa - e non so come - la disavventura di Capri, Bruno è stato la molla che mi ha spinto a rompere il bozzolo dellle convenzioni alto-borghesi; un maestro sul piano poetico; un fratello maggiore su quello dell’intelletto, dell’interagire col reale
dellle convenzioni alto-borghesi; un maestro sul piano poetico; un fratello maggiore su quello dell’intelletto, dell’interagire col reale nella ricerca del senso e nell’accettazione del non senso.
nella ricerca del senso e nell’accettazione del non senso. uesto, malgrado tutto quel di lui che ci ha sempre divisi: il sincretismo pseudo-religioso (con pratiche Macumba e Umbanda e
uesto, malgrado tutto quel di lui che ci ha sempre divisi: il sincretismo pseudo-religioso (con pratiche Macumba e Umbanda e un fervente culto a Iemanjà); l’egocentrismo esasperante; la vanità masturbatoria e geniale; la pratica incessante della menzogna; il
un fervente culto a Iemanjà); l’egocentrismo esasperante; la vanità masturbatoria e geniale; la pratica incessante della menzogna; il cinismo anaffettivo, fonte del suo amorale malvivere; la disperazione esistenziale di fondo, fonte prima del mio affetto per lui.
cinismo anaffettivo, fonte del suo amorale malvivere; la disperazione esistenziale di fondo, fonte prima del mio affetto per lui. Non possono non apparire autentici e anche importanti gli interrogativi che Bruno si è posto e ci ha posto in modo a volte sublime
Non possono non apparire autentici e anche importanti gli interrogativi che Bruno si è posto e ci ha posto in modo a volte sublime con la sua poesia; inautentiche e spesso malvage sono le risposte che si è dato e che ha inflitto nella prassi di ogni giorno. Ha innalzato
con la sua poesia; inautentiche e spesso malvage sono le risposte che si è dato e che ha inflitto nella prassi di ogni giorno. Ha innalzato a sua bandiera “Entre a gnose e o real (talvez) o acordo”, l'accordo (forse) tra la gnosi e il reale, puntando sopra “O triunfo moral do
a sua bandiera “Entre a gnose e o real (talvez) o acordo”, l'accordo (forse) tra la gnosi e il reale, puntando sopra “O triunfo moral do cognitivo”, il trionfo morale della consapevolezza; questo trionfo gli è tragicamente mancato, e chi gli vuol bene si augura che il Dio
cognitivo”, il trionfo morale della consapevolezza; questo trionfo gli è tragicamente mancato, e chi gli vuol bene si augura che il Dio Padre di ogni misericordia non gliene stia chiedendo conto. La tragedia è che - ne sono convinto - Bruno è sempre stato in buona fede.
Padre di ogni misericordia non gliene stia chiedendo conto. La tragedia è che - ne sono convinto - Bruno è sempre stato in buona fede. La tragedia è che la buona fede dell’ingannato è effetto di un inganno teso con arte, con l’arte propria del grande ingannatore. Chi ha a
La tragedia è che la buona fede dell’ingannato è effetto di un inganno teso con arte, con l’arte propria del grande ingannatore. Chi ha a cuore la sua sorte si ricordi che ora Bruno non può giovare a se stesso, può solo ricevere da altri, grazie alla preghiera, il frutto di
cuore la sua sorte si ricordi che ora Bruno non può giovare a se stesso, può solo ricevere da altri, grazie alla preghiera, il frutto di quell’amore che lui ha negato, per quel che mi consta, fino a tre anni prima di morire di AIDS. E questo nonostante la sua eclatante
quell’amore che lui ha negato, per quel che mi consta, fino a tre anni prima di morire di AIDS. E questo nonostante la sua eclatante pseudo conversione, che nel 2004 ho visto con dolore quanto fosse ancora tutta e soltanto nel mondo dellla gnose. Se qualcuno avesse
pseudo conversione, che nel 2004 ho visto con dolore quanto fosse ancora tutta e soltanto nel mondo dellla gnose. Se qualcuno avesse visto, e non solo nelle parole o negli scritti, segni di una fede passata dalla gnose al real negli ultimi anni della vita di Bruno, mi dia
visto, e non solo nelle parole o negli scritti, segni di una fede passata dalla gnose al real negli ultimi anni della vita di Bruno, mi dia conforto dandone notizia. Questo spazio è aperto ad altre testimonianze
conforto dandone notizia. Questo spazio è aperto ad altre testimonianze  La spinta ricevuta nonostante tuttto da Bruno a vivere più a fondo la mia inquietudine è stata penso un aiuto provvidenziale.
La spinta ricevuta nonostante tuttto da Bruno a vivere più a fondo la mia inquietudine è stata penso un aiuto provvidenziale. Anche - e forse soprattutto - grazie ad essa, mi sono sentito libero di cercare un modo più concreto e vitale di relazionarmi con me
Anche - e forse soprattutto - grazie ad essa, mi sono sentito libero di cercare un modo più concreto e vitale di relazionarmi con me stesso e con il mio creatore, per poi sperimentare, attraverso il Cammino Neocatecumenale, un amore paterno finalmente rispettoso
stesso e con il mio creatore, per poi sperimentare, attraverso il Cammino Neocatecumenale, un amore paterno finalmente rispettoso della mia libertà e contento e fiero di avermi fatto così come sono. Per questo nell’ultimo giorno mi alzerò a difendere Bruno, a dire la
della mia libertà e contento e fiero di avermi fatto così come sono. Per questo nell’ultimo giorno mi alzerò a difendere Bruno, a dire la mia gratitudine per lui e per chi l’ha mandato nella mia vita.
mia gratitudine per lui e per chi l’ha mandato nella mia vita.
 della RAI. È appena giunto a Roma un giovane poeta brasiliano, interessato a tradurre le sue poesie in portoghese. Gli ha appena
della RAI. È appena giunto a Roma un giovane poeta brasiliano, interessato a tradurre le sue poesie in portoghese. Gli ha appena trovato una sistemazione presso un pensionato per studenti, ora vorrebbe trovargli compagnia, in modo che lo lasci respirare un po’.
trovato una sistemazione presso un pensionato per studenti, ora vorrebbe trovargli compagnia, in modo che lo lasci respirare un po’. Scaglia ha un figlio sui vent’anni, Franco, che ama scrivere. Potrebbe fargli da chaperon? Scaglia parla col figlio; Franco non ne vuol
Scaglia ha un figlio sui vent’anni, Franco, che ama scrivere. Potrebbe fargli da chaperon? Scaglia parla col figlio; Franco non ne vuol sapere, ma ha un amico che scrive poesie, e gli chiede a sua volta di provare ad occuparsene.
sapere, ma ha un amico che scrive poesie, e gli chiede a sua volta di provare ad occuparsene.  Fu così che, per fare un favore a Franco Scaglia, andai a cercare Bruno Tolentino alla Foresteria del Foro Italico, un complesso di
Fu così che, per fare un favore a Franco Scaglia, andai a cercare Bruno Tolentino alla Foresteria del Foro Italico, un complesso di palazzine di fronte al MInistero degli Esteri dove trovano alloggio giovani stranieri con borse di studio.
palazzine di fronte al MInistero degli Esteri dove trovano alloggio giovani stranieri con borse di studio. Tolentino aveva 24 anni, quattro più di me. Riusciva già ad esprimersi in italiano con proprietà di linguaggio e non molti errori.
Tolentino aveva 24 anni, quattro più di me. Riusciva già ad esprimersi in italiano con proprietà di linguaggio e non molti errori. La sua pronuncia era ancora molto brasileira, ma in un paio di mesi avrebbe assimilato la lingua fin quasi a non farsi riconoscere come
La sua pronuncia era ancora molto brasileira, ma in un paio di mesi avrebbe assimilato la lingua fin quasi a non farsi riconoscere come straniero. Le uniche imperfezioni le aveva nello scrivere: l’uso improprio delle doppie e del plurale dei sostantivi. Gli sono rimaste
straniero. Le uniche imperfezioni le aveva nello scrivere: l’uso improprio delle doppie e del plurale dei sostantivi. Gli sono rimaste anche perché, con segreta soddisfazione, mi sono sempre ben guardato ad aiutarlo a corigersi: cosa non fa l’invidia.
anche perché, con segreta soddisfazione, mi sono sempre ben guardato ad aiutarlo a corigersi: cosa non fa l’invidia. Facemmo subito amicizia, parlavamo quasi solo di poesia. Non so dove trovasse il tempo per vedere Ungaretti: stavamo sempre
Facemmo subito amicizia, parlavamo quasi solo di poesia. Non so dove trovasse il tempo per vedere Ungaretti: stavamo sempre insieme. D’altra parte non mi ha mai mostrato neanche l’abbozzo di una traduzione dei versi del nostro grande poeta, né mi risulta
insieme. D’altra parte non mi ha mai mostrato neanche l’abbozzo di una traduzione dei versi del nostro grande poeta, né mi risulta abbia mai pubblicato niente a tal riguardo. Se pure ha mai lavorato con/per Ungaretti, è finito tutto nel cestino. Chi ne sa di più si
abbia mai pubblicato niente a tal riguardo. Se pure ha mai lavorato con/per Ungaretti, è finito tutto nel cestino. Chi ne sa di più si faccia avanti, anche perché é finita pure sui giornali italiani la leggenda che sia stato addirittura suo ospite. Forse a colazione, un paio
faccia avanti, anche perché é finita pure sui giornali italiani la leggenda che sia stato addirittura suo ospite. Forse a colazione, un paio Ricordo che la prima cosa che mi colpì fu che se ne andasse in giro con buona parte del viso dietro una dozzina di piccoli cerotti.
Ricordo che la prima cosa che mi colpì fu che se ne andasse in giro con buona parte del viso dietro una dozzina di piccoli cerotti. Mi disse che servivano a nascondere alcuni sfoghi, forse di fegato. Mi accorsi poi che, dietro, la pelle era del tutto sana. Saperlo
Mi disse che servivano a nascondere alcuni sfoghi, forse di fegato. Mi accorsi poi che, dietro, la pelle era del tutto sana. Saperlo protetto da quei cerottini come un cavaliere dalla visiera dell’elmo me lo fece percepire nella sua fragilità e fece sì che cominciassi ad
protetto da quei cerottini come un cavaliere dalla visiera dell’elmo me lo fece percepire nella sua fragilità e fece sì che cominciassi ad affezionarmi a lui.
affezionarmi a lui. Cominciai presto a portarlo a mangiare a casa mia. Faceva ancora caldo, sulla camicia a maniche corte, spesso a scacchettoni,
Cominciai presto a portarlo a mangiare a casa mia. Faceva ancora caldo, sulla camicia a maniche corte, spesso a scacchettoni, portava sembre un gilè bordato che sapeva molto di Sudamerica. Papà lo guardava con una punta di ironia nello sguardo. Non si lasciò
portava sembre un gilè bordato che sapeva molto di Sudamerica. Papà lo guardava con una punta di ironia nello sguardo. Non si lasciò mai sfuggire un apprezzamento, ma amava chiamarlo (in assenza) Buffalo Bill. Il messaggio che intendeva lanciarmi con quel
mai sfuggire un apprezzamento, ma amava chiamarlo (in assenza) Buffalo Bill. Il messaggio che intendeva lanciarmi con quel soprannome era fin troppo chiaro: nonostante i sorrisi e i suoi modi compiti, nonostante l’immensa erudizione multilingue di cui
soprannome era fin troppo chiaro: nonostante i sorrisi e i suoi modi compiti, nonostante l’immensa erudizione multilingue di cui faceva noncurante sfoggio, si trattava di un avventuriero da cui stare in guardia.
faceva noncurante sfoggio, si trattava di un avventuriero da cui stare in guardia. Mio padre era un professionista dell’alta borghesia, uso a poche parole e all’understatement: quando era sostituto avvocato
Mio padre era un professionista dell’alta borghesia, uso a poche parole e all’understatement: quando era sostituto avvocato generale dello Stato, riempiva i moduli alla voce “professione” limitandosi a scrivere: “impiegato statale”. Il criterio ispiratore della sua
generale dello Stato, riempiva i moduli alla voce “professione” limitandosi a scrivere: “impiegato statale”. Il criterio ispiratore della sua vita era l’oraziana aurea mediocritas. Faceva l’avvocato e l’unico figlio maschio, nonostante ahimé scrivesse versi, non a caso studiava
vita era l’oraziana aurea mediocritas. Faceva l’avvocato e l’unico figlio maschio, nonostante ahimé scrivesse versi, non a caso studiava giurisprudenza. Non aveva alcuna intenzione di farselo portar via. Per di più aveva ancora in casa una figlia femmina appena
giurisprudenza. Non aveva alcuna intenzione di farselo portar via. Per di più aveva ancora in casa una figlia femmina appena diciannovenne; ma Bruno puntava a me e si teneva prudentemente a distanza da Francesca; era troppo intelligente per mettere mio
diciannovenne; ma Bruno puntava a me e si teneva prudentemente a distanza da Francesca; era troppo intelligente per mettere mio padre in ulteriore allarme.
padre in ulteriore allarme. Dell’aurea mediocritas, si sa, fa parte anche una normale vita sessuale, e nel 1964 era considersato normale che un ventenne (oggi
Dell’aurea mediocritas, si sa, fa parte anche una normale vita sessuale, e nel 1964 era considersato normale che un ventenne (oggi un dodicenne) avesse già avuto le sue prime “esperienze”. Purtroppo quella baciapile della Merlin era riuscita sei anni prima a far
un dodicenne) avesse già avuto le sue prime “esperienze”. Purtroppo quella baciapile della Merlin era riuscita sei anni prima a far chiudere i bordelli e le puttane non erano più sotto vigilanza medica. Mio padre finì così col rivolgersi a quel Buffalo Bill dall’aria
chiudere i bordelli e le puttane non erano più sotto vigilanza medica. Mio padre finì così col rivolgersi a quel Buffalo Bill dall’aria vissuta perché si adoperasse a liberarmi dalle fisime bigotte (frutto dell’influenza che Padre Pio esercitava su mia madre, sua figlia
vissuta perché si adoperasse a liberarmi dalle fisime bigotte (frutto dell’influenza che Padre Pio esercitava su mia madre, sua figlia spirituale) e potessi finalmente entrare nel mondo adulto lasciandomi dietro gli impacci della verginità.
spirituale) e potessi finalmente entrare nel mondo adulto lasciandomi dietro gli impacci della verginità. Fu così che Bruno ed io, nel novembre del 1964, avemmo con mia sorpresa via libera per trascorrere nella casa di Capri una
Fu così che Bruno ed io, nel novembre del 1964, avemmo con mia sorpresa via libera per trascorrere nella casa di Capri una ventina di giorni. A Capri Bruno si adoperò attivamente a liberare dalle fisime bigotte le giovani straniere che alloggiavano al
ventina di giorni. A Capri Bruno si adoperò attivamente a liberare dalle fisime bigotte le giovani straniere che alloggiavano al Quisisana con la mamma. Quanto a me, si adoperò attivamente per liberare dagli impacci della verginità il mio posteriore. La notte
Quisisana con la mamma. Quanto a me, si adoperò attivamente per liberare dagli impacci della verginità il mio posteriore. La notte che, dopo una giornata passata a scrivere versi, entrò al buio nella mia stanza e si infilò tutto nudo nel mio letto, la custodisco nella
che, dopo una giornata passata a scrivere versi, entrò al buio nella mia stanza e si infilò tutto nudo nel mio letto, la custodisco nella memoria, come Gedeone la notte in cui sconfisse i figli dell’oriente - più numerosi delle cavallette - con trecento brocche e trecento
memoria, come Gedeone la notte in cui sconfisse i figli dell’oriente - più numerosi delle cavallette - con trecento brocche e trecento fiaccole. Ero solo un ragazzino nevrotico, del tutto infatuato di uno degli uomini più fascinosi che Dio abbia messo al mondo nel
fiaccole. Ero solo un ragazzino nevrotico, del tutto infatuato di uno degli uomini più fascinosi che Dio abbia messo al mondo nel ventesimo secolo. L’unica cosa di me che gli diedi quella notte fu la catenina d’oro con la Madonna di Pompei che portavo al collo. In
ventesimo secolo. L’unica cosa di me che gli diedi quella notte fu la catenina d’oro con la Madonna di Pompei che portavo al collo. In più di quarant’anni di amicizia, nonostante la sua conclamata bisessualità e il reciproco affetto, non mi si è avvicinato mai più così.
più di quarant’anni di amicizia, nonostante la sua conclamata bisessualità e il reciproco affetto, non mi si è avvicinato mai più così. Cinque anni dopo, uno psicanalista mi avrebbe detto che non riusciva in alcun modo a spiegarsi come allora non fossi diventato
Cinque anni dopo, uno psicanalista mi avrebbe detto che non riusciva in alcun modo a spiegarsi come allora non fossi diventato omosessuale. Mio padre non ne ha mai saputo nulla.
omosessuale. Mio padre non ne ha mai saputo nulla. Sono solo uno dei tanti/e che hanno subito, in Europa come in Brasile, il fascino di Bruno Tolentino e che hanno vissuto con lui
Sono solo uno dei tanti/e che hanno subito, in Europa come in Brasile, il fascino di Bruno Tolentino e che hanno vissuto con lui un’amicizia mai su un piano di parità, se non per pochi eletti di cui non ho notizia. Mi ha impressionato per i punti di contatto con la
un’amicizia mai su un piano di parità, se non per pochi eletti di cui non ho notizia. Mi ha impressionato per i punti di contatto con la mia esperienza il ricordo di lui, pubblicato nell’aprile 2008 dal giornalista inglese Chris Miller, che è stato suo amico e convivente.
mia esperienza il ricordo di lui, pubblicato nell’aprile 2008 dal giornalista inglese Chris Miller, che è stato suo amico e convivente. Conferma in pieno l’idea che mi ero fatto dei 15 anni vissuti da Bruno in Inghilterra
Conferma in pieno l’idea che mi ero fatto dei 15 anni vissuti da Bruno in Inghilterra Per ora la mia testimonianza si ferma qui. Voglio solo provare a descrivere quale posto occupa l’amicizia con Bruno nella mia
Per ora la mia testimonianza si ferma qui. Voglio solo provare a descrivere quale posto occupa l’amicizia con Bruno nella mia vita. Per me, presto rimossa - e non so come - la disavventura di Capri, Bruno è stato la molla che mi ha spinto a rompere il bozzolo
vita. Per me, presto rimossa - e non so come - la disavventura di Capri, Bruno è stato la molla che mi ha spinto a rompere il bozzolo dellle convenzioni alto-borghesi; un maestro sul piano poetico; un fratello maggiore su quello dell’intelletto, dell’interagire col reale
dellle convenzioni alto-borghesi; un maestro sul piano poetico; un fratello maggiore su quello dell’intelletto, dell’interagire col reale nella ricerca del senso e nell’accettazione del non senso.
nella ricerca del senso e nell’accettazione del non senso. uesto, malgrado tutto quel di lui che ci ha sempre divisi: il sincretismo pseudo-religioso (con pratiche Macumba e Umbanda e
uesto, malgrado tutto quel di lui che ci ha sempre divisi: il sincretismo pseudo-religioso (con pratiche Macumba e Umbanda e un fervente culto a Iemanjà); l’egocentrismo esasperante; la vanità masturbatoria e geniale; la pratica incessante della menzogna; il
un fervente culto a Iemanjà); l’egocentrismo esasperante; la vanità masturbatoria e geniale; la pratica incessante della menzogna; il cinismo anaffettivo, fonte del suo amorale malvivere; la disperazione esistenziale di fondo, fonte prima del mio affetto per lui.
cinismo anaffettivo, fonte del suo amorale malvivere; la disperazione esistenziale di fondo, fonte prima del mio affetto per lui. Non possono non apparire autentici e anche importanti gli interrogativi che Bruno si è posto e ci ha posto in modo a volte sublime
Non possono non apparire autentici e anche importanti gli interrogativi che Bruno si è posto e ci ha posto in modo a volte sublime con la sua poesia; inautentiche e spesso malvage sono le risposte che si è dato e che ha inflitto nella prassi di ogni giorno. Ha innalzato
con la sua poesia; inautentiche e spesso malvage sono le risposte che si è dato e che ha inflitto nella prassi di ogni giorno. Ha innalzato a sua bandiera “Entre a gnose e o real (talvez) o acordo”, l'accordo (forse) tra la gnosi e il reale, puntando sopra “O triunfo moral do
a sua bandiera “Entre a gnose e o real (talvez) o acordo”, l'accordo (forse) tra la gnosi e il reale, puntando sopra “O triunfo moral do cognitivo”, il trionfo morale della consapevolezza; questo trionfo gli è tragicamente mancato, e chi gli vuol bene si augura che il Dio
cognitivo”, il trionfo morale della consapevolezza; questo trionfo gli è tragicamente mancato, e chi gli vuol bene si augura che il Dio Padre di ogni misericordia non gliene stia chiedendo conto. La tragedia è che - ne sono convinto - Bruno è sempre stato in buona fede.
Padre di ogni misericordia non gliene stia chiedendo conto. La tragedia è che - ne sono convinto - Bruno è sempre stato in buona fede. La tragedia è che la buona fede dell’ingannato è effetto di un inganno teso con arte, con l’arte propria del grande ingannatore. Chi ha a
La tragedia è che la buona fede dell’ingannato è effetto di un inganno teso con arte, con l’arte propria del grande ingannatore. Chi ha a cuore la sua sorte si ricordi che ora Bruno non può giovare a se stesso, può solo ricevere da altri, grazie alla preghiera, il frutto di
cuore la sua sorte si ricordi che ora Bruno non può giovare a se stesso, può solo ricevere da altri, grazie alla preghiera, il frutto di quell’amore che lui ha negato, per quel che mi consta, fino a tre anni prima di morire di AIDS. E questo nonostante la sua eclatante
quell’amore che lui ha negato, per quel che mi consta, fino a tre anni prima di morire di AIDS. E questo nonostante la sua eclatante pseudo conversione, che nel 2004 ho visto con dolore quanto fosse ancora tutta e soltanto nel mondo dellla gnose. Se qualcuno avesse
pseudo conversione, che nel 2004 ho visto con dolore quanto fosse ancora tutta e soltanto nel mondo dellla gnose. Se qualcuno avesse visto, e non solo nelle parole o negli scritti, segni di una fede passata dalla gnose al real negli ultimi anni della vita di Bruno, mi dia
visto, e non solo nelle parole o negli scritti, segni di una fede passata dalla gnose al real negli ultimi anni della vita di Bruno, mi dia conforto dandone notizia. Questo spazio è aperto ad altre testimonianze
conforto dandone notizia. Questo spazio è aperto ad altre testimonianze  La spinta ricevuta nonostante tuttto da Bruno a vivere più a fondo la mia inquietudine è stata penso un aiuto provvidenziale.
La spinta ricevuta nonostante tuttto da Bruno a vivere più a fondo la mia inquietudine è stata penso un aiuto provvidenziale. Anche - e forse soprattutto - grazie ad essa, mi sono sentito libero di cercare un modo più concreto e vitale di relazionarmi con me
Anche - e forse soprattutto - grazie ad essa, mi sono sentito libero di cercare un modo più concreto e vitale di relazionarmi con me stesso e con il mio creatore, per poi sperimentare, attraverso il Cammino Neocatecumenale, un amore paterno finalmente rispettoso
stesso e con il mio creatore, per poi sperimentare, attraverso il Cammino Neocatecumenale, un amore paterno finalmente rispettoso della mia libertà e contento e fiero di avermi fatto così come sono. Per questo nell’ultimo giorno mi alzerò a difendere Bruno, a dire la
della mia libertà e contento e fiero di avermi fatto così come sono. Per questo nell’ultimo giorno mi alzerò a difendere Bruno, a dire la mia gratitudine per lui e per chi l’ha mandato nella mia vita.
mia gratitudine per lui e per chi l’ha mandato nella mia vita.
Elena Bono
Giuseppe De Gennaro
Giuliana Gattoni
Dicembre 1964. Da quattro mesi mi ero messo con Roberta. Aveva 17 anni, tre meno di me, e si era trasferia da poco a Roma da Milano. Frequentava il primo anno del liceo classico. Per le vacanze natalizie venne sua ospite a Roma la Gattoni, sua compagna di
Milano. Frequentava il primo anno del liceo classico. Per le vacanze natalizie venne sua ospite a Roma la Gattoni, sua compagna di banco a Milano e sua amica del cuore.
banco a Milano e sua amica del cuore. Avevamo entrambi grande interesse a conoscerci; erano gli anni delle lunghe passeggiate e delle interminabili chiacchierate, mai
Avevamo entrambi grande interesse a conoscerci; erano gli anni delle lunghe passeggiate e delle interminabili chiacchierate, mai di nulla. Con Giuliana non era possibile. Condivideva con me una intensa sete di vivere, e ad occhi bene aperti. Anche lei si esprimeva
di nulla. Con Giuliana non era possibile. Condivideva con me una intensa sete di vivere, e ad occhi bene aperti. Anche lei si esprimeva in poesia. Fu un bell’incontro. Roberta ci ascoltava contenta, parlava poco, mai a caso. Si unì più di una volta alla compagnia Bruno
in poesia. Fu un bell’incontro. Roberta ci ascoltava contenta, parlava poco, mai a caso. Si unì più di una volta alla compagnia Bruno Tolentino, che allora aveva 24 anni e che frequentavo da appena tre mesi. Ad esprimersi era il più bravo, più maturo e profondo di noi,
Tolentino, che allora aveva 24 anni e che frequentavo da appena tre mesi. Ad esprimersi era il più bravo, più maturo e profondo di noi, almeno in apparenza, ma troppo accentratore; tra l’altro con i suoi modi da acchiappafemmine, anzi, da acchiappatuttti, ci faceva
almeno in apparenza, ma troppo accentratore; tra l’altro con i suoi modi da acchiappafemmine, anzi, da acchiappatuttti, ci faceva sentire un po’ a disagio, per cui spesso sceglievamo di vederci senza di lui. Venne l’Epifania del ‘65 e Giuliana ripartì per Milano.
sentire un po’ a disagio, per cui spesso sceglievamo di vederci senza di lui. Venne l’Epifania del ‘65 e Giuliana ripartì per Milano. La fraterna amicizia e l’intimo sodalizio poetico con lei cominciò così e maturò col crescere, in uno scambio reso più ricco dal
La fraterna amicizia e l’intimo sodalizio poetico con lei cominciò così e maturò col crescere, in uno scambio reso più ricco dal fascino che ha sempre avuto su entrambi la persona di Gesù e il suo Vangelo. Allora non c’era Internet né il cellulare, e le interurbane
fascino che ha sempre avuto su entrambi la persona di Gesù e il suo Vangelo. Allora non c’era Internet né il cellulare, e le interurbane pesavano sui bilanci familiari. Iniziò una fitta corrispondenza: lei indirizzava spesso le lettere a Roberta e Pierluigi, ognuno di noi le
pesavano sui bilanci familiari. Iniziò una fitta corrispondenza: lei indirizzava spesso le lettere a Roberta e Pierluigi, ognuno di noi le rispondeva per suo conto. E le buste, da e per Milano, spesso contenevano anche i fogli con i nostri versi.
rispondeva per suo conto. E le buste, da e per Milano, spesso contenevano anche i fogli con i nostri versi. Poi Giuliana finalmente si arrese alla corte di uno dei tanti fascinati dalla sua personalità, sposò Massimo e con lui si trasferì in
Poi Giuliana finalmente si arrese alla corte di uno dei tanti fascinati dalla sua personalità, sposò Massimo e con lui si trasferì in Canada, a Toronto. Continuammo a scriverci, tornammo a vederci talvolta d’estate nella sua casa di Rapalllo.
Canada, a Toronto. Continuammo a scriverci, tornammo a vederci talvolta d’estate nella sua casa di Rapalllo. Quando la storia con Roberta finì, il rapporto con lei, lungi dall’interrompersi, si approfondì, anche grazie al suo intelligente
Quando la storia con Roberta finì, il rapporto con lei, lungi dall’interrompersi, si approfondì, anche grazie al suo intelligente discernimento, per cui mai pretese in alcun modo di inserirsi nel doloroso frantumarsi di quello che era stato un grande amore.
discernimento, per cui mai pretese in alcun modo di inserirsi nel doloroso frantumarsi di quello che era stato un grande amore. Da Massimo Giuliana ebbe due figlie, Cecilia e Beatrice. Erano ancora adolescenti quando nell’86 si ammalò di tumore. Per il
Da Massimo Giuliana ebbe due figlie, Cecilia e Beatrice. Erano ancora adolescenti quando nell’86 si ammalò di tumore. Per il marito, per le figlie, voleva vivere. Venne da me a Roma per un pellegrinaggio alle reliquie della Santa Croce, poi a s. Giovanni
marito, per le figlie, voleva vivere. Venne da me a Roma per un pellegrinaggio alle reliquie della Santa Croce, poi a s. Giovanni Rotondo, alla tomba di Padre Pio. Fu l’ultimo viaggio che facemmo insieme. Tornò in Canada malata, ma con il cuore pacificato.
Rotondo, alla tomba di Padre Pio. Fu l’ultimo viaggio che facemmo insieme. Tornò in Canada malata, ma con il cuore pacificato. Il suo impegno poetico lo portò avanti finché ne ebbe la forza. Resta viva nella memoria di molti e nella sua poesia, che da queste
Il suo impegno poetico lo portò avanti finché ne ebbe la forza. Resta viva nella memoria di molti e nella sua poesia, che da queste pagine si apre al mondo.
pagine si apre al mondo.
 Milano. Frequentava il primo anno del liceo classico. Per le vacanze natalizie venne sua ospite a Roma la Gattoni, sua compagna di
Milano. Frequentava il primo anno del liceo classico. Per le vacanze natalizie venne sua ospite a Roma la Gattoni, sua compagna di banco a Milano e sua amica del cuore.
banco a Milano e sua amica del cuore. Avevamo entrambi grande interesse a conoscerci; erano gli anni delle lunghe passeggiate e delle interminabili chiacchierate, mai
Avevamo entrambi grande interesse a conoscerci; erano gli anni delle lunghe passeggiate e delle interminabili chiacchierate, mai di nulla. Con Giuliana non era possibile. Condivideva con me una intensa sete di vivere, e ad occhi bene aperti. Anche lei si esprimeva
di nulla. Con Giuliana non era possibile. Condivideva con me una intensa sete di vivere, e ad occhi bene aperti. Anche lei si esprimeva in poesia. Fu un bell’incontro. Roberta ci ascoltava contenta, parlava poco, mai a caso. Si unì più di una volta alla compagnia Bruno
in poesia. Fu un bell’incontro. Roberta ci ascoltava contenta, parlava poco, mai a caso. Si unì più di una volta alla compagnia Bruno Tolentino, che allora aveva 24 anni e che frequentavo da appena tre mesi. Ad esprimersi era il più bravo, più maturo e profondo di noi,
Tolentino, che allora aveva 24 anni e che frequentavo da appena tre mesi. Ad esprimersi era il più bravo, più maturo e profondo di noi, almeno in apparenza, ma troppo accentratore; tra l’altro con i suoi modi da acchiappafemmine, anzi, da acchiappatuttti, ci faceva
almeno in apparenza, ma troppo accentratore; tra l’altro con i suoi modi da acchiappafemmine, anzi, da acchiappatuttti, ci faceva sentire un po’ a disagio, per cui spesso sceglievamo di vederci senza di lui. Venne l’Epifania del ‘65 e Giuliana ripartì per Milano.
sentire un po’ a disagio, per cui spesso sceglievamo di vederci senza di lui. Venne l’Epifania del ‘65 e Giuliana ripartì per Milano. La fraterna amicizia e l’intimo sodalizio poetico con lei cominciò così e maturò col crescere, in uno scambio reso più ricco dal
La fraterna amicizia e l’intimo sodalizio poetico con lei cominciò così e maturò col crescere, in uno scambio reso più ricco dal fascino che ha sempre avuto su entrambi la persona di Gesù e il suo Vangelo. Allora non c’era Internet né il cellulare, e le interurbane
fascino che ha sempre avuto su entrambi la persona di Gesù e il suo Vangelo. Allora non c’era Internet né il cellulare, e le interurbane pesavano sui bilanci familiari. Iniziò una fitta corrispondenza: lei indirizzava spesso le lettere a Roberta e Pierluigi, ognuno di noi le
pesavano sui bilanci familiari. Iniziò una fitta corrispondenza: lei indirizzava spesso le lettere a Roberta e Pierluigi, ognuno di noi le rispondeva per suo conto. E le buste, da e per Milano, spesso contenevano anche i fogli con i nostri versi.
rispondeva per suo conto. E le buste, da e per Milano, spesso contenevano anche i fogli con i nostri versi. Poi Giuliana finalmente si arrese alla corte di uno dei tanti fascinati dalla sua personalità, sposò Massimo e con lui si trasferì in
Poi Giuliana finalmente si arrese alla corte di uno dei tanti fascinati dalla sua personalità, sposò Massimo e con lui si trasferì in Canada, a Toronto. Continuammo a scriverci, tornammo a vederci talvolta d’estate nella sua casa di Rapalllo.
Canada, a Toronto. Continuammo a scriverci, tornammo a vederci talvolta d’estate nella sua casa di Rapalllo. Quando la storia con Roberta finì, il rapporto con lei, lungi dall’interrompersi, si approfondì, anche grazie al suo intelligente
Quando la storia con Roberta finì, il rapporto con lei, lungi dall’interrompersi, si approfondì, anche grazie al suo intelligente discernimento, per cui mai pretese in alcun modo di inserirsi nel doloroso frantumarsi di quello che era stato un grande amore.
discernimento, per cui mai pretese in alcun modo di inserirsi nel doloroso frantumarsi di quello che era stato un grande amore. Da Massimo Giuliana ebbe due figlie, Cecilia e Beatrice. Erano ancora adolescenti quando nell’86 si ammalò di tumore. Per il
Da Massimo Giuliana ebbe due figlie, Cecilia e Beatrice. Erano ancora adolescenti quando nell’86 si ammalò di tumore. Per il marito, per le figlie, voleva vivere. Venne da me a Roma per un pellegrinaggio alle reliquie della Santa Croce, poi a s. Giovanni
marito, per le figlie, voleva vivere. Venne da me a Roma per un pellegrinaggio alle reliquie della Santa Croce, poi a s. Giovanni Rotondo, alla tomba di Padre Pio. Fu l’ultimo viaggio che facemmo insieme. Tornò in Canada malata, ma con il cuore pacificato.
Rotondo, alla tomba di Padre Pio. Fu l’ultimo viaggio che facemmo insieme. Tornò in Canada malata, ma con il cuore pacificato. Il suo impegno poetico lo portò avanti finché ne ebbe la forza. Resta viva nella memoria di molti e nella sua poesia, che da queste
Il suo impegno poetico lo portò avanti finché ne ebbe la forza. Resta viva nella memoria di molti e nella sua poesia, che da queste pagine si apre al mondo.
pagine si apre al mondo.
Carlo Striano
Gennaio 1966. Mia sorella Francesca cominciava a fare avanti e indietro fra Roma e Napoli, dove si era messa con Francesco Catalano, l’uomo che sposerà tre anni dopo, Francesco aveva per padre spirituale il gesuita Giuseppe De Gennaro. Lo incontrai per la
Catalano, l’uomo che sposerà tre anni dopo, Francesco aveva per padre spirituale il gesuita Giuseppe De Gennaro. Lo incontrai per la prima volta ad aprile, durante le vacanze di Pasqua trascorse a Napoli.
prima volta ad aprile, durante le vacanze di Pasqua trascorse a Napoli. De Gennaro aveva allora 34 anni, dodici più di me. Cercavo da tempo una guida spirituale, trovai anche un amico, per di più
De Gennaro aveva allora 34 anni, dodici più di me. Cercavo da tempo una guida spirituale, trovai anche un amico, per di più anch’egli poeta. Fu lui ad aiutarmi con sapienza a gestire, senza finirne soggiogato, l’amicizia con Bruno Tolentino, con cui ebbe più di
anch’egli poeta. Fu lui ad aiutarmi con sapienza a gestire, senza finirne soggiogato, l’amicizia con Bruno Tolentino, con cui ebbe più di un incontro. Quel che Bruno mi stava dando sul piano intellettuale e della maturazione poetica si integrò con l’influenza che ebbe su di
un incontro. Quel che Bruno mi stava dando sul piano intellettuale e della maturazione poetica si integrò con l’influenza che ebbe su di me il rapporto con Peppino - così cominciai presto a chiamarlo - grazie alla sua sapienza umana e cristiana e alla profondità del suo
me il rapporto con Peppino - così cominciai presto a chiamarlo - grazie alla sua sapienza umana e cristiana e alla profondità del suo percorso spirituale.
L’affinità che c’è tra noi portò in breve la nostra fraterna amicizia a un punto tale da renderlo incompatibile col rapporto di
percorso spirituale.
L’affinità che c’è tra noi portò in breve la nostra fraterna amicizia a un punto tale da renderlo incompatibile col rapporto di paternità/figliolanza spirituale, che si concluse, non senza sofferenza, nel giro di un paio d’anni.
paternità/figliolanza spirituale, che si concluse, non senza sofferenza, nel giro di un paio d’anni. Seguì un lungo periodo di rapporti più rarefatti, ma non per questo meno intensi. Fu lui a celebrare nel ‘69 le mie nozze con
Seguì un lungo periodo di rapporti più rarefatti, ma non per questo meno intensi. Fu lui a celebrare nel ‘69 le mie nozze con Roberta, che aveva ben conosciuto. Potevamo non vederci per anni, ma ad ogni incontro ci siamo ritrovati come fratelli.
Roberta, che aveva ben conosciuto. Potevamo non vederci per anni, ma ad ogni incontro ci siamo ritrovati come fratelli. A maggio del ‘91 padre De Gennaro, che da molti anni insegnava all’università dell’Aquila, inaugurò, col sostegno di madre Teresa
A maggio del ‘91 padre De Gennaro, che da molti anni insegnava all’università dell’Aquila, inaugurò, col sostegno di madre Teresa di Calcutta, il Dono di Gesù: un centro di sostegno spirituale e psicologico rivolto soprattutto ai tossicodipendenti. Da allora le nostre
di Calcutta, il Dono di Gesù: un centro di sostegno spirituale e psicologico rivolto soprattutto ai tossicodipendenti. Da allora le nostre frequentazioni si sono fatte sempre più intense.
frequentazioni si sono fatte sempre più intense. Nel 2012 Peppino ha compiuto 80 anni, ed io 68. La differenza di età non conta più, ma continua ad essere il fratello maggiore
Nel 2012 Peppino ha compiuto 80 anni, ed io 68. La differenza di età non conta più, ma continua ad essere il fratello maggiore che mi era sempre mancato.
che mi era sempre mancato.
 Catalano, l’uomo che sposerà tre anni dopo, Francesco aveva per padre spirituale il gesuita Giuseppe De Gennaro. Lo incontrai per la
Catalano, l’uomo che sposerà tre anni dopo, Francesco aveva per padre spirituale il gesuita Giuseppe De Gennaro. Lo incontrai per la prima volta ad aprile, durante le vacanze di Pasqua trascorse a Napoli.
prima volta ad aprile, durante le vacanze di Pasqua trascorse a Napoli. De Gennaro aveva allora 34 anni, dodici più di me. Cercavo da tempo una guida spirituale, trovai anche un amico, per di più
De Gennaro aveva allora 34 anni, dodici più di me. Cercavo da tempo una guida spirituale, trovai anche un amico, per di più anch’egli poeta. Fu lui ad aiutarmi con sapienza a gestire, senza finirne soggiogato, l’amicizia con Bruno Tolentino, con cui ebbe più di
anch’egli poeta. Fu lui ad aiutarmi con sapienza a gestire, senza finirne soggiogato, l’amicizia con Bruno Tolentino, con cui ebbe più di un incontro. Quel che Bruno mi stava dando sul piano intellettuale e della maturazione poetica si integrò con l’influenza che ebbe su di
un incontro. Quel che Bruno mi stava dando sul piano intellettuale e della maturazione poetica si integrò con l’influenza che ebbe su di me il rapporto con Peppino - così cominciai presto a chiamarlo - grazie alla sua sapienza umana e cristiana e alla profondità del suo
me il rapporto con Peppino - così cominciai presto a chiamarlo - grazie alla sua sapienza umana e cristiana e alla profondità del suo percorso spirituale.
L’affinità che c’è tra noi portò in breve la nostra fraterna amicizia a un punto tale da renderlo incompatibile col rapporto di
percorso spirituale.
L’affinità che c’è tra noi portò in breve la nostra fraterna amicizia a un punto tale da renderlo incompatibile col rapporto di paternità/figliolanza spirituale, che si concluse, non senza sofferenza, nel giro di un paio d’anni.
paternità/figliolanza spirituale, che si concluse, non senza sofferenza, nel giro di un paio d’anni. Seguì un lungo periodo di rapporti più rarefatti, ma non per questo meno intensi. Fu lui a celebrare nel ‘69 le mie nozze con
Seguì un lungo periodo di rapporti più rarefatti, ma non per questo meno intensi. Fu lui a celebrare nel ‘69 le mie nozze con Roberta, che aveva ben conosciuto. Potevamo non vederci per anni, ma ad ogni incontro ci siamo ritrovati come fratelli.
Roberta, che aveva ben conosciuto. Potevamo non vederci per anni, ma ad ogni incontro ci siamo ritrovati come fratelli. A maggio del ‘91 padre De Gennaro, che da molti anni insegnava all’università dell’Aquila, inaugurò, col sostegno di madre Teresa
A maggio del ‘91 padre De Gennaro, che da molti anni insegnava all’università dell’Aquila, inaugurò, col sostegno di madre Teresa di Calcutta, il Dono di Gesù: un centro di sostegno spirituale e psicologico rivolto soprattutto ai tossicodipendenti. Da allora le nostre
di Calcutta, il Dono di Gesù: un centro di sostegno spirituale e psicologico rivolto soprattutto ai tossicodipendenti. Da allora le nostre frequentazioni si sono fatte sempre più intense.
frequentazioni si sono fatte sempre più intense. Nel 2012 Peppino ha compiuto 80 anni, ed io 68. La differenza di età non conta più, ma continua ad essere il fratello maggiore
Nel 2012 Peppino ha compiuto 80 anni, ed io 68. La differenza di età non conta più, ma continua ad essere il fratello maggiore che mi era sempre mancato.
che mi era sempre mancato.
Bruno Tolentino
Autunno del 1966. Frequentavo l’ultimo anno di giurisprudenza, ma non volevo entrare, come mio padre, nel mondo del diritto. Mio zio Gianni Visco, l’unico che mi capiva, mi presentò a Carlo Fuscagni, allora caposervizio dei programmi culturali della TV (sì, ragazzi, la
zio Gianni Visco, l’unico che mi capiva, mi presentò a Carlo Fuscagni, allora caposervizio dei programmi culturali della TV (sì, ragazzi, la TV in quegli anni era solo RAI).
TV in quegli anni era solo RAI). Cominciai a collaborare e così conobbi un altro protetto di Fuscagni, Carlo Striano. Che tipo striano, pensai fra me. “A viale Mazzini
Cominciai a collaborare e così conobbi un altro protetto di Fuscagni, Carlo Striano. Che tipo striano, pensai fra me. “A viale Mazzini vacci in giacca e cravatta”, si era raccomandato lo zio, e non avevo fatto fatica a dargli retta, adeguandomi così all’uso corrente. Carlone
vacci in giacca e cravatta”, si era raccomandato lo zio, e non avevo fatto fatica a dargli retta, adeguandomi così all’uso corrente. Carlone no. Non si poteva che chiamarlo così, vista la mole e il portamento alla Bud Spencer. Lui veniva in maglione XXXXL portato a pelle,
no. Non si poteva che chiamarlo così, vista la mole e il portamento alla Bud Spencer. Lui veniva in maglione XXXXL portato a pelle, capelli ravviati con le dita e barba di un paio di giorni. Credo sia stato lui a lanciare la moda. Lo so che non è chic ma. per chi se lo stesse
capelli ravviati con le dita e barba di un paio di giorni. Credo sia stato lui a lanciare la moda. Lo so che non è chic ma. per chi se lo stesse domandando, voglio chiarire che la sua igiene personale era così curata da stonare col resto: sapeva di sapone di Marsiglia.
domandando, voglio chiarire che la sua igiene personale era così curata da stonare col resto: sapeva di sapone di Marsiglia. Ancora non mi capacito di come abbia potuto interessarsi a un signorino tutto azzimato che puzzava di borghesia lontano un miglio,
Ancora non mi capacito di come abbia potuto interessarsi a un signorino tutto azzimato che puzzava di borghesia lontano un miglio, prossimo a una laurea che lui aveva sdegnato quando gli mancava solo la discussione della tesi (su Teilhard de Chardin). Per di più lui
prossimo a una laurea che lui aveva sdegnato quando gli mancava solo la discussione della tesi (su Teilhard de Chardin). Per di più lui aveva quasi 26 anni e io ne avevo finiti da poco 22, e a quell’età quasi quattro anni di differenza non sono pochi. Eppure mi prese subito a
aveva quasi 26 anni e io ne avevo finiti da poco 22, e a quell’età quasi quattro anni di differenza non sono pochi. Eppure mi prese subito a benvolere; chissà, forse gli facevo tenerezza. Scrivevamo entrambi poesie, ma non ce lo dicemmo se non dopo qualche anno: la ritrosia,
benvolere; chissà, forse gli facevo tenerezza. Scrivevamo entrambi poesie, ma non ce lo dicemmo se non dopo qualche anno: la ritrosia, quella sì, ci accomunava. Di lui i primi due libri sono usciti postumi, il sottoscritto finora non ha pubblicato neanche un verso. Parlavamo
quella sì, ci accomunava. Di lui i primi due libri sono usciti postumi, il sottoscritto finora non ha pubblicato neanche un verso. Parlavamo di filosofia e di religione, e si discuteva ricordo con passione. Lui era dubitoso su tutto, e sempre con acute motivazioni. Se non riuscì a
di filosofia e di religione, e si discuteva ricordo con passione. Lui era dubitoso su tutto, e sempre con acute motivazioni. Se non riuscì a farmi ricredere sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia fu solo perché avevo paura di seguirlo fino in fondo nella sua logica
farmi ricredere sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia fu solo perché avevo paura di seguirlo fino in fondo nella sua logica stringente, e troncai a mezzo nascondendomi vigliaccamente dietro al dogma.
stringente, e troncai a mezzo nascondendomi vigliaccamente dietro al dogma. Carlone era la croce di Fuscagni, una croce portata con ostinato affetto, ma sempre una croce: li suo modo di lavorare era estroso,
Carlone era la croce di Fuscagni, una croce portata con ostinato affetto, ma sempre una croce: li suo modo di lavorare era estroso, variabilmente impuntuale, affidato al genio e alla sregolatezza di un’anima inquieta. Fuscagni si disperava: non poteva fare a meno di
variabilmente impuntuale, affidato al genio e alla sregolatezza di un’anima inquieta. Fuscagni si disperava: non poteva fare a meno di dargli lavoro ma a suo rischio e pericolo, vista la totale inaffidabilità del personaggio. Quando vide che eravamo diventati amici cominciò
dargli lavoro ma a suo rischio e pericolo, vista la totale inaffidabilità del personaggio. Quando vide che eravamo diventati amici cominciò a farci lavorare in coppia, e debbo dire che non mi sono mai arrabbiato tanto come con Carlone a quei tempi, ma mi sono anche divertito
a farci lavorare in coppia, e debbo dire che non mi sono mai arrabbiato tanto come con Carlone a quei tempi, ma mi sono anche divertito come mai prima in vita mia. Suo fratello maggiore, Raffaele, era un po’ più grosso e un po’ meno scombinato di lui. Carlone riusciva
come mai prima in vita mia. Suo fratello maggiore, Raffaele, era un po’ più grosso e un po’ meno scombinato di lui. Carlone riusciva spesso a inserirlo nella troupe, ed era Raffaele a trarci fuori dagli impicci con la sua straordinaria capacità di arrangiarsi. Altro che Aldo,
spesso a inserirlo nella troupe, ed era Raffaele a trarci fuori dagli impicci con la sua straordinaria capacità di arrangiarsi. Altro che Aldo, Giovanni e Giacomo: Carlo era il matto della compagnia, Raffaele il furbacchione e il sottoscritto sapeva fare il fesso come nessun altro.
Giovanni e Giacomo: Carlo era il matto della compagnia, Raffaele il furbacchione e il sottoscritto sapeva fare il fesso come nessun altro. Non conosco la nostalgia, ma tornerei indietro insieme a loro, se potessi.
Non conosco la nostalgia, ma tornerei indietro insieme a loro, se potessi. Quei tempi belli durarono meno di due anni, poi vinsi una selezione per radiotelecronisti e le nostre strade lavorative si separarono.
Quei tempi belli durarono meno di due anni, poi vinsi una selezione per radiotelecronisti e le nostre strade lavorative si separarono. Venne il 1970, e fu l’anno della svolta: entrambi, per vie diverse, ci lasciammo attrarre dalla prospettiva di vivere in modo più
Venne il 1970, e fu l’anno della svolta: entrambi, per vie diverse, ci lasciammo attrarre dalla prospettiva di vivere in modo più concreto il l cristianesimo, grazie a un percorso che ci avrebbe finalmete trattato da quei pagani che eravamo, senza pretendere nulla che
concreto il l cristianesimo, grazie a un percorso che ci avrebbe finalmete trattato da quei pagani che eravamo, senza pretendere nulla che noi non fossimo contenti, anzi desiderosi di dare, basandoci su quello di buono che andavamo sperimentando. Era il Cammino
noi non fossimo contenti, anzi desiderosi di dare, basandoci su quello di buono che andavamo sperimentando. Era il Cammino Neocatecumenale. Fu allora che cominciammo a comunicare in modo esistenziale, ci scambiammo i nostri scritti, condividemmo la
Neocatecumenale. Fu allora che cominciammo a comunicare in modo esistenziale, ci scambiammo i nostri scritti, condividemmo la sorpresa di una vita spirituale che neanche ci aspettavamo potesse essere possibile vivere e divenimmo più che fratelli.
sorpresa di una vita spirituale che neanche ci aspettavamo potesse essere possibile vivere e divenimmo più che fratelli. Tornammo a lavorare insieme sette anni dopo, quando preferii la precarietà al posto fisso e lasciai la RAI. Lui su lavoro era quello di
Tornammo a lavorare insieme sette anni dopo, quando preferii la precarietà al posto fisso e lasciai la RAI. Lui su lavoro era quello di sempre, e grazie all’affetto di Fuscagni ci trovammo a spassarcela come un tempo, e con meno arrabbiature.
sempre, e grazie all’affetto di Fuscagni ci trovammo a spassarcela come un tempo, e con meno arrabbiature. Fu un’esperienza di un paio di mesi, perché nel frattempo Carlo si era sposato e con la moglie Mariangela e col figlio Davide aveva
Fu un’esperienza di un paio di mesi, perché nel frattempo Carlo si era sposato e con la moglie Mariangela e col figlio Davide aveva cominciato a svolgere un altro lavoro, pagato che meglio non si può: quello di annunciatore della Buona Notizia di Gesù con il Cammino
cominciato a svolgere un altro lavoro, pagato che meglio non si può: quello di annunciatore della Buona Notizia di Gesù con il Cammino Neocatecumenale in vari luoghi d’Italia e di Europa.
Neocatecumenale in vari luoghi d’Italia e di Europa. Sarebbe incompleta la mia testimonianza se tacessi della fine, per me tragica e inesplicabile, della nostra frequentazione. Carlo
Sarebbe incompleta la mia testimonianza se tacessi della fine, per me tragica e inesplicabile, della nostra frequentazione. Carlo aveva contratto nell’85 un’epatite che poi degenerò in cirrosi. La malattia durò quasi vent’anni, aggravandosi fno a condurlo alla morte.
aveva contratto nell’85 un’epatite che poi degenerò in cirrosi. La malattia durò quasi vent’anni, aggravandosi fno a condurlo alla morte. Le forze poco a poco gli diminuivano, ma non diminuiva il suo impegno di evangelizzatore. Un giorno di cui ho rimosso la data mi
Le forze poco a poco gli diminuivano, ma non diminuiva il suo impegno di evangelizzatore. Un giorno di cui ho rimosso la data mi comunicò che non voleva più vivere la nostra amicizia. Eravamo a Chiavari, in casa sua. Mi disse che sentiva la morte vicina e che voleva
comunicò che non voleva più vivere la nostra amicizia. Eravamo a Chiavari, in casa sua. Mi disse che sentiva la morte vicina e che voleva dedicare tutto il tempo che gli rimaneva alla sua missione e alla famiglia. Altri amici continuò a frequentarli, io sono stato scartato. Avevo
dedicare tutto il tempo che gli rimaneva alla sua missione e alla famiglia. Altri amici continuò a frequentarli, io sono stato scartato. Avevo evidentemente sopravvalutato l’attaccamento che i Natali passati in casa loro come in famiglia con lui, Mariangela e Davide (del quale
evidentemente sopravvalutato l’attaccamento che i Natali passati in casa loro come in famiglia con lui, Mariangela e Davide (del quale sono padrino), mi avevano fatto supporre. La ferita è ancora aperta. Ci chiariremo in cielo.
sono padrino), mi avevano fatto supporre. La ferita è ancora aperta. Ci chiariremo in cielo.
 zio Gianni Visco, l’unico che mi capiva, mi presentò a Carlo Fuscagni, allora caposervizio dei programmi culturali della TV (sì, ragazzi, la
zio Gianni Visco, l’unico che mi capiva, mi presentò a Carlo Fuscagni, allora caposervizio dei programmi culturali della TV (sì, ragazzi, la TV in quegli anni era solo RAI).
TV in quegli anni era solo RAI). Cominciai a collaborare e così conobbi un altro protetto di Fuscagni, Carlo Striano. Che tipo striano, pensai fra me. “A viale Mazzini
Cominciai a collaborare e così conobbi un altro protetto di Fuscagni, Carlo Striano. Che tipo striano, pensai fra me. “A viale Mazzini vacci in giacca e cravatta”, si era raccomandato lo zio, e non avevo fatto fatica a dargli retta, adeguandomi così all’uso corrente. Carlone
vacci in giacca e cravatta”, si era raccomandato lo zio, e non avevo fatto fatica a dargli retta, adeguandomi così all’uso corrente. Carlone no. Non si poteva che chiamarlo così, vista la mole e il portamento alla Bud Spencer. Lui veniva in maglione XXXXL portato a pelle,
no. Non si poteva che chiamarlo così, vista la mole e il portamento alla Bud Spencer. Lui veniva in maglione XXXXL portato a pelle, capelli ravviati con le dita e barba di un paio di giorni. Credo sia stato lui a lanciare la moda. Lo so che non è chic ma. per chi se lo stesse
capelli ravviati con le dita e barba di un paio di giorni. Credo sia stato lui a lanciare la moda. Lo so che non è chic ma. per chi se lo stesse domandando, voglio chiarire che la sua igiene personale era così curata da stonare col resto: sapeva di sapone di Marsiglia.
domandando, voglio chiarire che la sua igiene personale era così curata da stonare col resto: sapeva di sapone di Marsiglia. Ancora non mi capacito di come abbia potuto interessarsi a un signorino tutto azzimato che puzzava di borghesia lontano un miglio,
Ancora non mi capacito di come abbia potuto interessarsi a un signorino tutto azzimato che puzzava di borghesia lontano un miglio, prossimo a una laurea che lui aveva sdegnato quando gli mancava solo la discussione della tesi (su Teilhard de Chardin). Per di più lui
prossimo a una laurea che lui aveva sdegnato quando gli mancava solo la discussione della tesi (su Teilhard de Chardin). Per di più lui aveva quasi 26 anni e io ne avevo finiti da poco 22, e a quell’età quasi quattro anni di differenza non sono pochi. Eppure mi prese subito a
aveva quasi 26 anni e io ne avevo finiti da poco 22, e a quell’età quasi quattro anni di differenza non sono pochi. Eppure mi prese subito a benvolere; chissà, forse gli facevo tenerezza. Scrivevamo entrambi poesie, ma non ce lo dicemmo se non dopo qualche anno: la ritrosia,
benvolere; chissà, forse gli facevo tenerezza. Scrivevamo entrambi poesie, ma non ce lo dicemmo se non dopo qualche anno: la ritrosia, quella sì, ci accomunava. Di lui i primi due libri sono usciti postumi, il sottoscritto finora non ha pubblicato neanche un verso. Parlavamo
quella sì, ci accomunava. Di lui i primi due libri sono usciti postumi, il sottoscritto finora non ha pubblicato neanche un verso. Parlavamo di filosofia e di religione, e si discuteva ricordo con passione. Lui era dubitoso su tutto, e sempre con acute motivazioni. Se non riuscì a
di filosofia e di religione, e si discuteva ricordo con passione. Lui era dubitoso su tutto, e sempre con acute motivazioni. Se non riuscì a farmi ricredere sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia fu solo perché avevo paura di seguirlo fino in fondo nella sua logica
farmi ricredere sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia fu solo perché avevo paura di seguirlo fino in fondo nella sua logica stringente, e troncai a mezzo nascondendomi vigliaccamente dietro al dogma.
stringente, e troncai a mezzo nascondendomi vigliaccamente dietro al dogma. Carlone era la croce di Fuscagni, una croce portata con ostinato affetto, ma sempre una croce: li suo modo di lavorare era estroso,
Carlone era la croce di Fuscagni, una croce portata con ostinato affetto, ma sempre una croce: li suo modo di lavorare era estroso, variabilmente impuntuale, affidato al genio e alla sregolatezza di un’anima inquieta. Fuscagni si disperava: non poteva fare a meno di
variabilmente impuntuale, affidato al genio e alla sregolatezza di un’anima inquieta. Fuscagni si disperava: non poteva fare a meno di dargli lavoro ma a suo rischio e pericolo, vista la totale inaffidabilità del personaggio. Quando vide che eravamo diventati amici cominciò
dargli lavoro ma a suo rischio e pericolo, vista la totale inaffidabilità del personaggio. Quando vide che eravamo diventati amici cominciò a farci lavorare in coppia, e debbo dire che non mi sono mai arrabbiato tanto come con Carlone a quei tempi, ma mi sono anche divertito
a farci lavorare in coppia, e debbo dire che non mi sono mai arrabbiato tanto come con Carlone a quei tempi, ma mi sono anche divertito come mai prima in vita mia. Suo fratello maggiore, Raffaele, era un po’ più grosso e un po’ meno scombinato di lui. Carlone riusciva
come mai prima in vita mia. Suo fratello maggiore, Raffaele, era un po’ più grosso e un po’ meno scombinato di lui. Carlone riusciva spesso a inserirlo nella troupe, ed era Raffaele a trarci fuori dagli impicci con la sua straordinaria capacità di arrangiarsi. Altro che Aldo,
spesso a inserirlo nella troupe, ed era Raffaele a trarci fuori dagli impicci con la sua straordinaria capacità di arrangiarsi. Altro che Aldo, Giovanni e Giacomo: Carlo era il matto della compagnia, Raffaele il furbacchione e il sottoscritto sapeva fare il fesso come nessun altro.
Giovanni e Giacomo: Carlo era il matto della compagnia, Raffaele il furbacchione e il sottoscritto sapeva fare il fesso come nessun altro. Non conosco la nostalgia, ma tornerei indietro insieme a loro, se potessi.
Non conosco la nostalgia, ma tornerei indietro insieme a loro, se potessi. Quei tempi belli durarono meno di due anni, poi vinsi una selezione per radiotelecronisti e le nostre strade lavorative si separarono.
Quei tempi belli durarono meno di due anni, poi vinsi una selezione per radiotelecronisti e le nostre strade lavorative si separarono. Venne il 1970, e fu l’anno della svolta: entrambi, per vie diverse, ci lasciammo attrarre dalla prospettiva di vivere in modo più
Venne il 1970, e fu l’anno della svolta: entrambi, per vie diverse, ci lasciammo attrarre dalla prospettiva di vivere in modo più concreto il l cristianesimo, grazie a un percorso che ci avrebbe finalmete trattato da quei pagani che eravamo, senza pretendere nulla che
concreto il l cristianesimo, grazie a un percorso che ci avrebbe finalmete trattato da quei pagani che eravamo, senza pretendere nulla che noi non fossimo contenti, anzi desiderosi di dare, basandoci su quello di buono che andavamo sperimentando. Era il Cammino
noi non fossimo contenti, anzi desiderosi di dare, basandoci su quello di buono che andavamo sperimentando. Era il Cammino Neocatecumenale. Fu allora che cominciammo a comunicare in modo esistenziale, ci scambiammo i nostri scritti, condividemmo la
Neocatecumenale. Fu allora che cominciammo a comunicare in modo esistenziale, ci scambiammo i nostri scritti, condividemmo la sorpresa di una vita spirituale che neanche ci aspettavamo potesse essere possibile vivere e divenimmo più che fratelli.
sorpresa di una vita spirituale che neanche ci aspettavamo potesse essere possibile vivere e divenimmo più che fratelli. Tornammo a lavorare insieme sette anni dopo, quando preferii la precarietà al posto fisso e lasciai la RAI. Lui su lavoro era quello di
Tornammo a lavorare insieme sette anni dopo, quando preferii la precarietà al posto fisso e lasciai la RAI. Lui su lavoro era quello di sempre, e grazie all’affetto di Fuscagni ci trovammo a spassarcela come un tempo, e con meno arrabbiature.
sempre, e grazie all’affetto di Fuscagni ci trovammo a spassarcela come un tempo, e con meno arrabbiature. Fu un’esperienza di un paio di mesi, perché nel frattempo Carlo si era sposato e con la moglie Mariangela e col figlio Davide aveva
Fu un’esperienza di un paio di mesi, perché nel frattempo Carlo si era sposato e con la moglie Mariangela e col figlio Davide aveva cominciato a svolgere un altro lavoro, pagato che meglio non si può: quello di annunciatore della Buona Notizia di Gesù con il Cammino
cominciato a svolgere un altro lavoro, pagato che meglio non si può: quello di annunciatore della Buona Notizia di Gesù con il Cammino Neocatecumenale in vari luoghi d’Italia e di Europa.
Neocatecumenale in vari luoghi d’Italia e di Europa. Sarebbe incompleta la mia testimonianza se tacessi della fine, per me tragica e inesplicabile, della nostra frequentazione. Carlo
Sarebbe incompleta la mia testimonianza se tacessi della fine, per me tragica e inesplicabile, della nostra frequentazione. Carlo aveva contratto nell’85 un’epatite che poi degenerò in cirrosi. La malattia durò quasi vent’anni, aggravandosi fno a condurlo alla morte.
aveva contratto nell’85 un’epatite che poi degenerò in cirrosi. La malattia durò quasi vent’anni, aggravandosi fno a condurlo alla morte. Le forze poco a poco gli diminuivano, ma non diminuiva il suo impegno di evangelizzatore. Un giorno di cui ho rimosso la data mi
Le forze poco a poco gli diminuivano, ma non diminuiva il suo impegno di evangelizzatore. Un giorno di cui ho rimosso la data mi comunicò che non voleva più vivere la nostra amicizia. Eravamo a Chiavari, in casa sua. Mi disse che sentiva la morte vicina e che voleva
comunicò che non voleva più vivere la nostra amicizia. Eravamo a Chiavari, in casa sua. Mi disse che sentiva la morte vicina e che voleva dedicare tutto il tempo che gli rimaneva alla sua missione e alla famiglia. Altri amici continuò a frequentarli, io sono stato scartato. Avevo
dedicare tutto il tempo che gli rimaneva alla sua missione e alla famiglia. Altri amici continuò a frequentarli, io sono stato scartato. Avevo evidentemente sopravvalutato l’attaccamento che i Natali passati in casa loro come in famiglia con lui, Mariangela e Davide (del quale
evidentemente sopravvalutato l’attaccamento che i Natali passati in casa loro come in famiglia con lui, Mariangela e Davide (del quale sono padrino), mi avevano fatto supporre. La ferita è ancora aperta. Ci chiariremo in cielo.
sono padrino), mi avevano fatto supporre. La ferita è ancora aperta. Ci chiariremo in cielo.
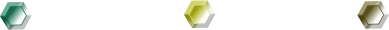
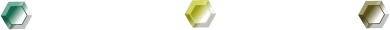
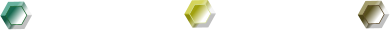
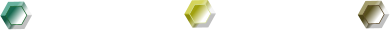
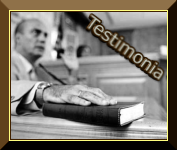
5 amici, 5 poeti
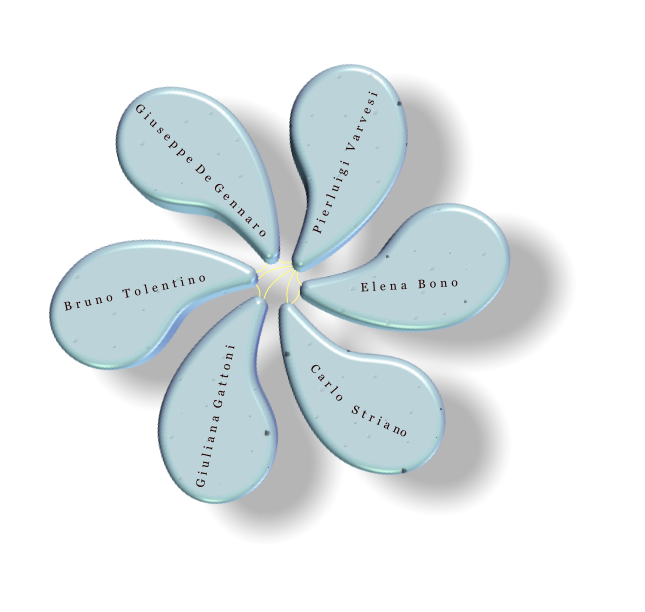





di Pierluigi Varvesi
Primi di giugno del 1988. Ero in Liguria, a Cavi di Lavagna, grazie all’ospitalità di un amico scrittore, Enrico Rovegno. Poco distante, a Chiavari, era Carlone (Carlo Striano), che un anno prima mi aveva introdotto alla poesia di Elena Bono. Riìcordo due ore di
distante, a Chiavari, era Carlone (Carlo Striano), che un anno prima mi aveva introdotto alla poesia di Elena Bono. Riìcordo due ore di viaggio da Chiavari a Pisa, durante le quali Carlone mi leggeva i versi della Bono mentre guidavo; e a tratti piangevo, mordendomi le
viaggio da Chiavari a Pisa, durante le quali Carlone mi leggeva i versi della Bono mentre guidavo; e a tratti piangevo, mordendomi le labbra perché non si accorgesse.
labbra perché non si accorgesse. Era un sabato, il 4 di giugno. Il giorno prima Carlone mi aveva detto che la domenica ci sarebbe stata a Lavagna (o forse a
Era un sabato, il 4 di giugno. Il giorno prima Carlone mi aveva detto che la domenica ci sarebbe stata a Lavagna (o forse a Chiavari, non riicordo) una pubblica lettura di versi della Bono, lei presente. Finalmente l’avrei vista. Chissà, forse avrei potuto sentirla
Chiavari, non riicordo) una pubblica lettura di versi della Bono, lei presente. Finalmente l’avrei vista. Chissà, forse avrei potuto sentirla parlare, avrei avuto la possibilità di stringerle la mano. Quella mattina scrissi dei versi, che intittolai Lettera a un divino cantore
parlare, avrei avuto la possibilità di stringerle la mano. Quella mattina scrissi dei versi, che intittolai Lettera a un divino cantore Il 5 giugno la serata dedicata a lei cominciò con l’ascolto di alcune sue poesie, lette in tal modo che da morta le avrebbe causato
Il 5 giugno la serata dedicata a lei cominciò con l’ascolto di alcune sue poesie, lette in tal modo che da morta le avrebbe causato una crisi di nervi, e da viva le portò appena agli occhi un velo di rassegnata tristezza. Ma poi finalmente la sua voce, intensa e viva
una crisi di nervi, e da viva le portò appena agli occhi un velo di rassegnata tristezza. Ma poi finalmente la sua voce, intensa e viva come l’aspettavo. Di quel che disse, mi resta oggi soltanto l’emozione. Quando tacque si fece silenzio e dagli astanti - saremo stati un
come l’aspettavo. Di quel che disse, mi resta oggi soltanto l’emozione. Quando tacque si fece silenzio e dagli astanti - saremo stati un centinaio o poco più - sgorgò infine un lungo, lungo applauso. Una voce dal palco domandò se qualcheduno in sala avesse da dire, da
centinaio o poco più - sgorgò infine un lungo, lungo applauso. Una voce dal palco domandò se qualcheduno in sala avesse da dire, da chiedere qualcosa. Tornò il silenzio. Mi ritrovai in piedi a chiederle se volesse ascoltare quei versi appena scrittti per lei. Lei acconsentì
chiedere qualcosa. Tornò il silenzio. Mi ritrovai in piedi a chiederle se volesse ascoltare quei versi appena scrittti per lei. Lei acconsentì sorridendo. Avevo 44 anni, facevo il giornalista in televisione, ma era la prima volta che dicevo in pubblico i miei versi. Mentre la voce
sorridendo. Avevo 44 anni, facevo il giornalista in televisione, ma era la prima volta che dicevo in pubblico i miei versi. Mentre la voce mi usciva non so come, sentivo le guance avvampare.
mi usciva non so come, sentivo le guance avvampare. Fu così che ebbe inizio la nostra amicizia e quella col suo sposo, Gian Maria, uomo di intelligenza e di dolcezza rare, di un
Fu così che ebbe inizio la nostra amicizia e quella col suo sposo, Gian Maria, uomo di intelligenza e di dolcezza rare, di un umorismo colto e stuzzicante, bello del suo amore per lei, persona che spero tra le prime a riabbracciare in cielo.
umorismo colto e stuzzicante, bello del suo amore per lei, persona che spero tra le prime a riabbracciare in cielo. Da allora Elena è per me come una sorella grande, punto di riferimento costante per il mio percorso di uomo e di poeta.
Da allora Elena è per me come una sorella grande, punto di riferimento costante per il mio percorso di uomo e di poeta.
 distante, a Chiavari, era Carlone (Carlo Striano), che un anno prima mi aveva introdotto alla poesia di Elena Bono. Riìcordo due ore di
distante, a Chiavari, era Carlone (Carlo Striano), che un anno prima mi aveva introdotto alla poesia di Elena Bono. Riìcordo due ore di viaggio da Chiavari a Pisa, durante le quali Carlone mi leggeva i versi della Bono mentre guidavo; e a tratti piangevo, mordendomi le
viaggio da Chiavari a Pisa, durante le quali Carlone mi leggeva i versi della Bono mentre guidavo; e a tratti piangevo, mordendomi le labbra perché non si accorgesse.
labbra perché non si accorgesse. Era un sabato, il 4 di giugno. Il giorno prima Carlone mi aveva detto che la domenica ci sarebbe stata a Lavagna (o forse a
Era un sabato, il 4 di giugno. Il giorno prima Carlone mi aveva detto che la domenica ci sarebbe stata a Lavagna (o forse a Chiavari, non riicordo) una pubblica lettura di versi della Bono, lei presente. Finalmente l’avrei vista. Chissà, forse avrei potuto sentirla
Chiavari, non riicordo) una pubblica lettura di versi della Bono, lei presente. Finalmente l’avrei vista. Chissà, forse avrei potuto sentirla parlare, avrei avuto la possibilità di stringerle la mano. Quella mattina scrissi dei versi, che intittolai Lettera a un divino cantore
parlare, avrei avuto la possibilità di stringerle la mano. Quella mattina scrissi dei versi, che intittolai Lettera a un divino cantore Il 5 giugno la serata dedicata a lei cominciò con l’ascolto di alcune sue poesie, lette in tal modo che da morta le avrebbe causato
Il 5 giugno la serata dedicata a lei cominciò con l’ascolto di alcune sue poesie, lette in tal modo che da morta le avrebbe causato una crisi di nervi, e da viva le portò appena agli occhi un velo di rassegnata tristezza. Ma poi finalmente la sua voce, intensa e viva
una crisi di nervi, e da viva le portò appena agli occhi un velo di rassegnata tristezza. Ma poi finalmente la sua voce, intensa e viva come l’aspettavo. Di quel che disse, mi resta oggi soltanto l’emozione. Quando tacque si fece silenzio e dagli astanti - saremo stati un
come l’aspettavo. Di quel che disse, mi resta oggi soltanto l’emozione. Quando tacque si fece silenzio e dagli astanti - saremo stati un centinaio o poco più - sgorgò infine un lungo, lungo applauso. Una voce dal palco domandò se qualcheduno in sala avesse da dire, da
centinaio o poco più - sgorgò infine un lungo, lungo applauso. Una voce dal palco domandò se qualcheduno in sala avesse da dire, da chiedere qualcosa. Tornò il silenzio. Mi ritrovai in piedi a chiederle se volesse ascoltare quei versi appena scrittti per lei. Lei acconsentì
chiedere qualcosa. Tornò il silenzio. Mi ritrovai in piedi a chiederle se volesse ascoltare quei versi appena scrittti per lei. Lei acconsentì sorridendo. Avevo 44 anni, facevo il giornalista in televisione, ma era la prima volta che dicevo in pubblico i miei versi. Mentre la voce
sorridendo. Avevo 44 anni, facevo il giornalista in televisione, ma era la prima volta che dicevo in pubblico i miei versi. Mentre la voce mi usciva non so come, sentivo le guance avvampare.
mi usciva non so come, sentivo le guance avvampare. Fu così che ebbe inizio la nostra amicizia e quella col suo sposo, Gian Maria, uomo di intelligenza e di dolcezza rare, di un
Fu così che ebbe inizio la nostra amicizia e quella col suo sposo, Gian Maria, uomo di intelligenza e di dolcezza rare, di un umorismo colto e stuzzicante, bello del suo amore per lei, persona che spero tra le prime a riabbracciare in cielo.
umorismo colto e stuzzicante, bello del suo amore per lei, persona che spero tra le prime a riabbracciare in cielo. Da allora Elena è per me come una sorella grande, punto di riferimento costante per il mio percorso di uomo e di poeta.
Da allora Elena è per me come una sorella grande, punto di riferimento costante per il mio percorso di uomo e di poeta.









